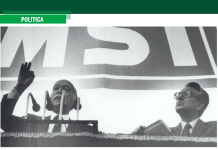Troppo spesso vengono confusi con i pentiti. Ma se di qualcosa è probabile che prima o poi possano “pentirsi”, è quella di aver denunciato estorsioni, racket, minacce e prepotenze di stampo mafioso. Sono i testimoni di giustizia, uomini e donne che non solo di quel sistema non fanno parte – a differenza, appunto, dei collaboratori di giustizia -, ma che a differenza di troppi, scelgono anche di denunciarlo.
E lo Stato, li dimentica. Nonostante facciano parte del sistema: sono inseriti nell’ordinamento italiano, riconosciuti dalla legge (n.8 del 1991) e inquadrati nel servizio centrale di protezione, (struttura interforze inquadrata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno italiano), che dovrebbe occuparsi della loro tutela e incolumità fisica. Ma anche qui, accomunati ai collaboratori.
A dicembre dell’anno scorso, i ministri Angelino Alfano e Marianna Madia firmarono decreto per dare attuazione alla legge, partorita nel 2013 dal governo Letta, sulle assunzioni dei testimoni di giustizia.
Tuttora carta non validata, per così dire, perché non ancora approvata, il testo aveva accolto la proposta dall’Associazione nazionale testimoni di giustizia, presieduta da Ignazio Cutrò. Secondo le disposizioni di legge, i testimoni di giustizia dovrebbero essere integrati nella Pubblica amministrazione «con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute al fine di garantire loro un regime sicuro e nello stesso tempo qualificato di integrazione economica e sociale». Ai tempi, riguardava 84 persone più i loro familiari. Oggi, molte di più.
Avendo dovuto abbandonare la propria terra e il proprio lavoro, spesso non recuperabile anni dopo, l’assunzione da parte di Stato, Regioni e Comuni sembrerebbe un atto di giustizia e riconoscimento del sacrificio fatto. Cosa alla quale ha provveduto la Regione Sicilia, e alla quale invece ha e sta continuando a fare Vincenzo De Luca, al quale la questione è stata più volte sollecitata. Ma evidentemente la questione non rientra nelle priorità dell’agenda del governatore campano.
«Questo provvedimento riconosce il debito morale dello Stato verso persone che si sono messe in gioco per il bene di tutti», aveva commentato ai tempi do Luigi Ciotti, cogliendo il senso alla base del provvedimento. Permettendo, tra l’altro, attraverso le loro denunce e i numerosi arresti e sequestri da esse scaturiti, di recuperare negli anni milioni di euro sottratte alle casse dello stato dalle associazioni mafiose. Un tributo più che dovuto, dunque, a chi contribuisce materialmente a riordinare la nostra società.
Ecco perché oggi si sono ritrovati tutti davanti al ministero degli Interni. Eppure, ancora una volta, sono rimasti inascoltati.
«Da stamane fuori al Viminale, ma come di consueto dal Palazzo emerge un costante silenzio tranne il via vai degli addetti alla sicurezza che ci controllano a vista», racconta Luigi Coppola, portavoce del Gruppo testimoni di giustizia. «Ciò che a noi davvero interessa stenta ad arrivare», ovvero la promessa che Alfano fece durante il convegno del 28 ottobre, in cui il ministro dichiarò che bisognava stare vicino ai testimoni di giustizia: «Oggi, sia Alfano che Bubbico (viceministro degli Interni, ndr) si sono rintanati nel palazzo – racconta Coppola, che per tutto il giorno assieme a qualche decina di altri testimoni, ha presenziato davanti alle porte (chiuse) del palazzo – e sembra che non abbiano intenzioni di darci risposte certe sul quando ci saranno le ormai famose assunzioni che ancora vengono strumentalizzate a livello politico e basta».
Nessuna udienza concessa e nessuna legge approvata, dunque, da parte di Alfano. «Siamo veramente stanchi di elemosinare i nostri diritti si sfoga Coppola – Sono le solite prese in giro all’italiana».
«Noi testimoni di giustizia non vogliamo diventare nè eroi da commemorare, nè trame per un film. Noi vogliamo vivere e far vivere dignitosamente le nostre famiglie», aveva già spiegato Luigi Coppola, che fra le altre cose, coordina uno sportello antiracket a Boscoreale. Proprio qui, le sue denunce nel 2001, avevano portato a 30 condanne definitive e alla decapitazione di numerosi clan campani. Ma dal 2010, il ministero dell’Interno gli revoca la scorta e vigilanza, perché essendo arrivato il processo in Cassazione l’anno prima, lui viene ormai ritenuto fuori pericolo e i suoi «impegni giudiziari sono da tempo terminati».
Quello che non è terminato, invece, è il debito che ha lo Stato con queste persone. Se manca quello, manca il riconoscimento reale dell’importanza della loro scelta. «Cosi si offendono i principi ed i valori della legalità – ci dice a fine giornata Coppola -. Ma noi andiamo avanti e non ci lasceremo intimidire da nessuno».
Facile credergli, viste le scelte da loro compiute. Meno facile, è accettare la latitanza delle Istituzioni.