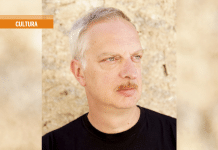Left aveva intervistato Ermanno Rea, lo scrittore scomparso oggi, il 29 novembre 2014. Riproponiamo qui le sue parole, ancora attualissime.
«Il signor Renzi vuole fare il partito della nazione? Prima pensi a unirla, la nazione, perché adesso è spaccata». Parla della frattura tra Nord e Sud dell’Italia, Ermanno Rea, e parla anche del presidente del Consiglio e del suo programma di «unanimismo elettorale» che però, avverte lo scrittore, non serve al Paese. Anzi, potrebbe renderlo ancora più immobile: un’altra occasione persa dopo 150 anni di unità rimasta sulla carta. E le ricette del presidente del Consiglio, a proposito di integrazione nazionale, continua Rea, non portano nulla di nuovo rispetto ai suoi predecessori Berlusconi, Monti e Letta.
Abbiamo incontrato lo scrittore napoletano nei giorni in cui lo scontro tra sindacati e premier aveva raggiunto una durezza mai vista finora a sinistra. Anche se già in precedenza Renzi non aveva risparmiato – talvolta con uscite non propriamente tenere – chi all’interno del Pd aveva mostrato di avere un pensiero diverso dal suo. Insomma, quella del premier – per iperbole, certo – potrebbe sembrare una gestione del potere che richiama la «polverizzazione di ogni forma di dissenso» come scrive Ermanno Rea in Mistero napoletano (Einaudi) la storia di una donna comunista, allo stesso tempo utopista e ribelle, schiacciata dall’ortodossia comunista nella Napoli degli anni Cinquanta.
Durante l’incontro con Rea nella sua bella casa romana popolata di libri e fotografie («scattate con la Leica») verrebbe quasi da azzardare una domanda su un eventuale, ipotetico parallelismo tra i due partiti e i due leader. «Ma quelli di Togliatti e Renzi sono due mondi diversi!» esclama sorridendo questo elegante signore di 87 anni dalla barba candida e dagli occhi chiarissimi. Giornalista de l’Unità negli anni Cinquanta – quando dominava la figura di Giorgio Amendola, il “maestro” del presidente Napolitano – Rea ha vissuto in prima persona quel clima politico di controllo e di sospetto che si insinuava lentamente nelle vite delle persone, fino a distruggerle. Accadde alla Francesca di Mistero napoletano, così come al personaggio dell’ultimo libro Il caso Piegari (Feltrinelli) fatto impazzire dal comunismo allora imperante sotto il Vesuvio. Ritorna poi lo scrittore sul confronto tra passato e presente: «Io non sono un difensore a oltranza di Togliatti ma devo dire che era di una cultura sterminata, di una raffinatezza… Renzi, invece, nella sua aggressività rivela una rozzezza di fondo, percepisce come un primitivo che il proprio successo sta lì e cerca di cavalcarlo nel modo più spregiudicato». Ma un parallelismo tra la politica di ieri e quella di oggi, utile a comprendere la crisi attuale, invece è evidente e drammatico allo stesso tempo. «La questione meridionale», afferma convinto lo scrittore.
Nel suo ultimo libro Il caso Piegari quando parla di «attualità di una sconfitta» si riferisce alla questione meridionale?
Sì, è proprio la questione meridionale che può essere affrontata solo come questione nazionale. È questa l’attualità della storia che racconto nel libro. A Napoli negli anni Cinquanta c’era un medico di grandissimo talento, Guido Piegari, uno scienziato che aveva una cultura storica gigantesca e che gestiva il gruppo Gramsci, molto importante in città in quegli anni. Lui dissente da Giorgio Amendola (responsabile della Commissione meridionale del Pci, ndr), critica la sua visione del meridionalismo e giudica il dirigente comunista uno che non promuove una politica a favore dell’integrazione nazionale, gramscianamente intesa nell’incontro della classe operaia del Nord con i contadini del Sud. Piegari viene espulso dal Pci. Come sempre, mettendo in moto una macchina del fango – si dice che è mezzo pazzo – e provocando in lui anche un disastro psicologico. Come il mio amico Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto per gli studi filosofici, che faceva parte del gruppo Gramsci, io opto per la visione proposta da Guido Piegari che affermava la necessità dell’integrazione nazionale.
Veniamo all’oggi: quali sono le conseguenze della mancata integrazione tra Nord e Sud?
I dati dell’ultimo rapporto Svimez parlano chiaro, addirittura si denuncia il rischio di desertificazione per il Sud. Io sono convinto che l’Italia non sarà in grado di uscire dal suo baratro fino a quando non realizzerà una unità nazionale. Se uno oggi mi dovesse chiedere qual è la malattia del Paese, la mia risposta convinta sarebbe questa: un’infezione profonda e lontana mai sanata che si è sempre più aggravata, la frattura tra Nord e Sud. Adesso perdiamo tutti: anche il ricco Nord è in crisi, e le periferie scoppiano là non meno che a Roma o Napoli. Com’è possibile che l’Italia, in una situazione di questo genere, possa riuscire a trovare una sua credibilità anche internazionale e una sua capacità di rigenerarsi? Tornando a ciò che racconto nel libro, esiste una responsabilità comunista? Su questo sono cauto, il Pci ha avuto tanti torti ma anche tanti meriti. Io sostengo solo che non si è mai voluto rivedere autocriticamente la vicenda della questione meridionale e riuscire a separare, come si suol dire, il bambino dall’acqua sporca.
Il partito della nazione lanciato da Matteo Renzi in una direzione del Pd di un mese fa – tra l’altro resuscitando il progetto di Pier Ferdinando Casini – potrebbe rappresentare allora la soluzione per risolvere il problema dell’unità d’Italia?
Per risponderle cito un articolo di Ernesto Galli della Loggia – che scrive cose di cui io non condivido quasi mai nulla – ma che nel 2010 sul Corriere della Sera aveva sollevato il problema dell’unità nazionale. Su cui, fino ad un certo punto, mi trovava d’accordo. Galli della Loggia infatti scriveva che chi fosse riuscito a rinsaldare il patto tra Nord e Sud si sarebbe installato al centro dell’azione politica «diventando forza egemone per un lungo tempo a venire». Va bene, ma se si parla di partito nazionale, per amor del cielo, io lo intendo nel senso di un partito che abbia la possibilità di integrare finalmente un Paese diviso da 150 anni, non di creare una “specie” al contrario. Il rischio è creare un equivoco bestiale perché il signor Renzi quando parla di partito della nazione parla di un consenso generalizzato alle sue idee e alla sua politica, ma cosa c’entra questo con la soluzione del problema? Al contrario, solo una sinistra vera può assumere su di sé questo ideale, questa bandiera e portarla avanti. Il partito della nazione va bene in quanto integrazione della nazione, ma non in quanto unanimismo elettorale che poi è l’obiettivo vero del signor Renzi. Lui vuole un bel pantano immobile. Ma questo è semplicemente un ulteriore modo di degradare quello che invece è un obiettivo politico di grande rilievo.
Lei quindi non vede proposte concrete nella politica del Governo indirizzate a risolvere la frattura esistente tra il Nord e il Sud del Paese?
Renzi non propone nulla di strategico. È un barcamenarsi, cercando di premiare ora una parte e ora un’altra. Le sue scelte tendono a ribadire il vecchio, a riconfermare quello che già c’era. Il mutamento è puramente formale, di facciata. Tutto il processo che va da Berlusconi a Monti fino ad arrivare a Letta e a Renzi, cosa ha portato di nuovo? Cambiare tutto perché tutto resti uguale: mi pare che il Gattopardo trionfi ancora una volta. Il quieta non movere. Tornando poi al successo di Renzi – che io giudico estremamente provvisorio – deriva dalle parti più fragili del Paese oppure da quelle più interessate. Infatti, il ceto imprenditoriale plaude fragorosamente a questo personaggio perché si sente rassicurato in quello che fa. E poi, se la politica è rappresentanza, Renzi chi rappresenta? Per il momento c’è una massa amorfa che applaude.
Nel sottotitolo del suo saggio La fabbrica dell’obbedienza si legge del «lato oscuro e complice degli italiani». Che cosa significa?
Qui mi rifaccio al filosofo napoletano di metà Ottocento Bertrando Spaventa. Lui sosteneva una tesi affascinante di cui mi approprio. La tesi è questa: il cittadino responsabile viene inventato in Italia con l’Umanesimo, la piazza, il palazzo comunale. Ma con la Controriforma costui viene in pratica espulso dal Paese e da cittadino reponsabile diviene suddito deresponsabilizzato. Perché? La storia è semplice, la raccontiamo anche ai ragazzini alle scuole medie. Mentre Lutero in Germania traduce la Bibbia in tedesco, esorta il popolo ad avere un rapporto diretto con Dio, moltiplicando quindi il senso di responsabilità, in Italia, al contrario, Santa Romana Chiesa sancisce che il rapporto con Dio passa attraverso il suo ministro, che assolve il fedele. E questo porta alla creazione del suddito deresponsabilizzato. Se c’è un difetto nella cultura media italiana, è proprio la mancanza di senso di responsabilità. A proposito di Togliatti, uno dei suoi grandi torti è stato proprio quello di aver pensato che senza la Chiesa nulla era possibile e che ogni tentativo di modificare il Paese sarebbe stato inutile. È stato succube dell’idea dell’incontro, dell’intreccio, del compromesso con il cattolicesimo che è una costante della storia italiana.
L’ultima domanda è sul futuro. Lei che è stato candidato con la lista Tsipras alle europee pensa che sia possibile che in Italia nasca un partito dal basso come è accaduto per Podemos, frutto degli Indignados?
Non ho la palla di vetro, so che in Italia, non meno che in Grecia e in Spagna, esiste un’opinione pubblica di tutto rispetto. Ci sono persone capaci, di tutte le età. Potrei citarne tante. Soltanto alcune sere fa sentivo Stefano Rodotà e Benedetta Tobagi ospiti della trasmissione Otto e mezzo. Due poli opposti, una ragazzina e un signore ottantenne che ci mostrano un’Italia bella, onesta, intelligente. Non è tutto così nero, ne esistono ancora migliaia di esemplari umani di questo genere.